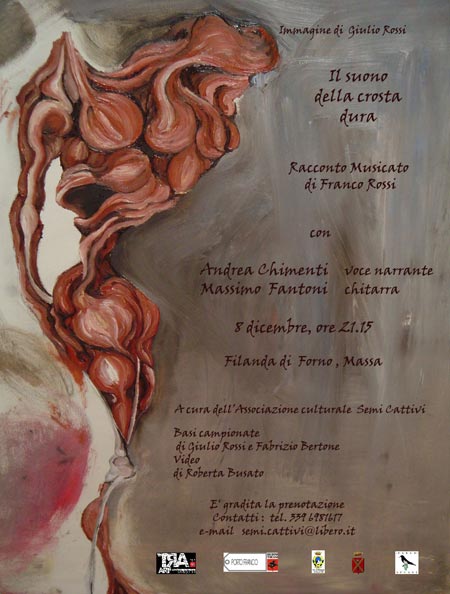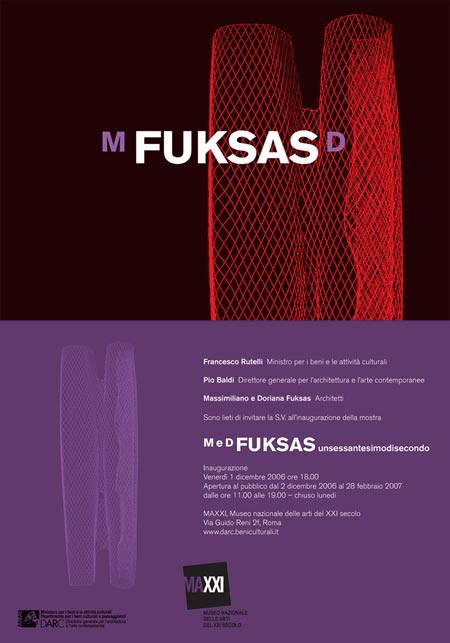Arnioni di alabastro in una cava del volterrano (foto: Sara Benzi)
L’artigianato alabastrino, elemento primario dell’identità culturale della zona del volterrano, pare avere da sempre alternato momenti di splendore a periodi di stasi. Molti sono stati i dibattiti sulle cause di questa dinamica, e pare che le responsabilità delle strategie imprenditoriali siano destinate a convivere con quelle delle vicende economiche contingenti. Ma se, come ha scritto Enrico Fiumi, autorevole studioso di questa preziosa pietra, “fattori politici ed economici distraggono delle generazioni dall’arte congenita, questa non muore: la cenere della materia nasconde la scintilla della tradizione ed in forme nuove, in nuove applicazioni, l’industria trova la ragione della sua rinascita”1. Sembra che questa dinamica, questa sorta di periodicità insita nella storia dell’alabastro sia tutt’oggi attuale, e questa perenne scintilla continua a farne vivere la tradizione, a farne parlare e scrivere le generazioni che si susseguono. L’energia grazie alla quale la città di Volterra riesce sempre e comunque a far rinascere questo misterioso materiale, probabilmente dovuta alla necessità innata di sfruttare le risorse naturali del territorio e trasformatasi nel tempo in vero e proprio sistema culturale e tecnico, contribuisce anche oggi, pur vivendo un momento di crisi produttiva, a far interessare alla sua natura ed alla sua storia ed a cercare una volta di più di raccontarla e farla conoscere, quanto meno in minima parte.
Il materiale
La narrazione necessita di una breve premessa, una piccola presentazione di ciò di cui stiamo parlando: il nome alabastro2 indica generalmente due classi mineralogiche distinte, il solfato di calcio idrato (CaSO42H2O) e il carbonato di calcio (CaCO3). La prima classe costituisce l’alabastro gessoso o del volterrano, la seconda l’alabastro calcareo od orientale. Il materiale del quale ci occupiamo appartiene alla prima classe, maggiormente tenera e lavorabile; all’interno di questa può essere distinto l’alabastro di Volterra, che va dal “cenerino” al “gabbro”, dall'”agata bionda” al “bardiglio”, e quello di Castellina Marittima, superiore in purezza e trasparenza, tra i cui blocchi alcuni, traslucidi, privi di impurezze, ossidazioni e scorie argillose, vengono denominati “scaglione”.

Campioni di alabastro: scaglione bianco, agata stilano, cipollone agata biondo
L’alabastro si presenta in blocchi, spesso ovoidali, denominati “arnioni”, incassati in una robusta veste di argilla dalla quale vengono estratti grazie all’abilità ed all’esperienza degli escavatori. Una volta estratto e ripulito il blocco, questo viene inizialmente lavorato dal tornitore o dallo squadratore, passando successivamente nelle mani dell’ornatista, dell’animalista o dello scultore che grazie alla loro maestria, riescono a fare emergere la magia di questa materia che, attraverso la sua mutevolezza e fragilità appare insieme vetro e pietra, nelle trasparenze fredde dello scaglione o nella luminosità dorata dell’agata.
Arte o produzione di massa? Un quesito attraverso i secoli
Simile al marmo ma di più facile lavorabilità e di minore resistenza agli agenti atmosferici, l’alabastro è stato da sempre escluso dai materiali architettonici principali, e relagato in posizione secondaria per interni ed oggettistica, dove, grazie anche alla sua particolare morbidezza, ha comunque avuto occasione di trasformarsi in oggetti di altissima qualità artistica. Ampiamente conosciuto, come già accennato, fin dall’epoca egizia, questo materiale, abbondantemente presente nella provincia di Pisa3, fu ampiamente utilizzato dalla civiltà etrusca fin dal IV sec. a.C., in una delimitata zona coincidente con il territorio di Volterra, principalmente per la produzione di urne cinerarie (oltre 600 conservate al Museo Guarnacci).

Urna cineraria etrusca conservata presso il Museo Guarnacci di Volterra (foto: Sara Benzi)
Successivamente, in epoca romana, all’alabastro venne preferito il marmo delle Apuane, provocando il declino del suo utilizzo, che venne ripreso solo nella seconda metà del 1500 principalmente per la creazione di oggetti d’arte sacra. Da allora l’alabastro cominciò ad essere protagonista di un duplice utilizzo, dettato da due distinte esigenze e tendenze che spesse volte hanno tentato di sovrapporsi per venire in aiuto l’una dell’altra. Riscoperto per la realizzazione di oggetti artistici, consoni alla natura della materia, e quindi riservato ad un pubblico ristretto, l’alabastro si avviò verso un nuovo successo soltanto nel secolo successivo, quando cominciò ad essere utilizzato anche per la produzione di oggetti artigianali seriali finalizzati ad un commercio popolare. Questo costrinse il mondo artigiano a metodi di produzione che diminuirono la qualità dei manufatti, contribuendo ad un generale declino del prestigio di questo materiale litico.
Una nuova rinascita: l’Officina Inghirami
Se dalla seconda metà del Seicento agli ultimi decenni del Settecento l’industria alabastrina proseguì senza particolari orientamenti o cambi di rotta, l’ultimo decennio del XVIII secolo accolse quello che diverrà uno dei protagonisti della storia di questa affascinante materia. Dalla produzione dei cosiddetti “marmai” che producevano perlopiù lampade, scatole per il tabacco ed “anime”4 di alabastro, la lavorazione di questa pietra trasse nuovo slancio dall’opera di Marcello Inghirami Fei. Questo giovane ed illuminato volterrano, allora solo venticinquenne, nel 1791 organizzò a proprie spese una Officina per l’alabastro, quasi in risposta a quella relazione granducale sullo stato di Volterra, scritta da Antonino di Niccolò Viviani nel 1766 dove si legge: “se vi fosse maniera di perfezionare o aumentare le manifatture mediante l’introduzione di nuovi edifici, macchine e istrumenti o mediante l’aiuto di qualche lume che potesse darsi agli artefici sopra la loro lavorazione”, alla quale venne risposto con la proposta di istituire nel territorio volterrano una pubblica scuola di disegno. L’Officina Inghirami, che si stabilì nei locali dell’ex Monastero di S. Dalmazio, nata come vero e proprio laboratorio e trasformatasi nel tempo in un ibrido fra scuola e fabbrica, accolse al suo interno più di 100 lavoranti e svariati maestri provenienti anche dall’estero. Interessatosi alla lavorazione della pietra volterrana fin dalla sua prima gioventù, Inghirami, alla ricerca di una soluzione alla crisi imminente, focalizzò la sua attenzione sul fatto che la realtà locale non sarebbe stata in grado di fare rinascere la manifattura alabastrina senza ricorrere ad aiuti e stimoli esterni alle proprie mura e senza una nuova attenzione nei confronti della formazione. Venne dato quindi avvio ad un’impresa di ampio respiro, basata su un progetto commerciale di carattere internazionale. Inghirami basò la produzione della sua officina sul ritorno alle fonti della tradizione classica, uniformandola nello stesso tempo alle possibilità ed ai gusti dei suoi tempi. Arrivò quindi a creare un vero e proprio catalogo di oggetti legati al gusto di fine secolo, tutti rigorosamente riportanti il marchio di fabbrica, raccolti e presentati in un esemplare manifeste scritto in lingua francese che pubblicizzava la vendita di vasi, casse per orologi, riproduzioni di elementi architettonici e copie di numerose opere e sculture del repertorio classico, prodotti tutti rigorosamente con la pietra locale5. Una collezione di copie artistiche, che per la prima volta nella storia dell’alabastro, esplicitarono la possibilità di una produzione seriale di una oggettistica di qualità, commerciabile a prezzi ragionevoli.
A distanza di soli otto anni però, nel 1799, l’impresa, già in crisi nell’ultimo periodo, fallì; oltre ad aver formato artigiani di indubbio valore artistico, rimase tuttavia il segno di un seme gettato, il quale contribuì all’immediata rinascita dell’industria alabastrina e del benessere di Volterra.

Orologio con Arianna, Teseo e il Minotauro – Fabbrica Inghirami, alabastro di Castellina (foto tratta da: M. Cozzi, Alabastro – Volterra dal Settecento all’Art Deco, Cantini ed., Firenze, 1986)
La fortuna dell’industria alabastrina nel corso del XIX secolo
Pur se sfociata in un fallimento, l’esperienza di Marcello Inghirami offrì un nuovo impulso grazie al quale la sorte dell’industria alabastrina riuscì a risollevarsi in tempi brevi. In lenta ascesa fino al 1850, la produzione in alabastro subì una crescita vertiginosa fino al 1870 circa.
La produzione ebbe un continuo incremento durante il XIX secolo grazie soprattutto al rapporto che riuscì ad instaurare con i mercati esteri, dato che sempre più palese risultava il fatto che l’alabastro era maggiormente apprezzato all’estero che nel Granducato. Occasione di conoscenza furono le Esposizioni internazionali alle quali le manifatture volterrane parteciparono attivamente: oltre a Firenze, infatti, le Esposizioni di Londra e Parigi fornirono l’occasione di far conoscere ad un vasto pubblico di commercianti e consumatori questa manifattura artistica.
Altro fenomeno di fondamentale importanza fu quello dei cosiddetti “viaggiatori”: tradizione nata nel 1804 grazie a Francesco Cari, proveniente dalla Fabbrica Inghirami, questa si moltiplicò a partire dal 18206, quando sempre più artigiani intrapresero viaggi verso i porti di tutto il mondo per accompagnare i manufatti venduti e cercare di incrementarne il mercato, attraverso una sperimentazione assolutamente vincente che donò nuovi spunti culturali alla produzione.Così, insieme al predominante stile neoclassico, si affacciarono nuove tendenze stilistiche che spaziavano dal neo-manierismo ad elementi orientali sfocianti in un gusto eclettico catterizzante parte della produzione ottocentesca.
I decenni centrali del secolo furono caratterizzati dalla presenza di importanti nomi per la storia di questa affascinante pietra; degni di nota risultano in particolare due personaggi che, in maniera diversa, offrirono a questo artigianato artistico nuovi spunti ed occasioni di fortuna. Per primo Amerigo Viti, fratello di quel Giuseppe “viaggiatore”, oltre ad aprire scuole ed avviare un importante laboratorio, indisse concorsi artistici per il miglioramento della produzione, fondò una fabbrica di mosaici e sperimentò, grazie alla collaborazione con i maestri dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, il commesso in alabastro attraverso una nuova tecnica da lui stesso ideata.
Altro artista di estimabile maestria fu Luigi Albino Funaioli, già premiato all’Esposizione fiornetina del 1861, e ricco di un’esperienza londinese pluriennale, arrivò a creare un proprio linguaggio, non esente da influenze “ingresque”, definibile “microscultura” o “glittica”. Attraverso la tecnica del bassorilievo a due o tre piani, Funaioli ritrasse innumerevoli illustri personaggi in splendidi cammei di alabastro, facendosi conoscere nei più celebri salotti dell’epoca; ma il suo rimase un episodio isolato nella storia della lavorazione di questa pietra.

Tavolo ottocentesco in alabastro scaglione. Ecomuseo dell’alabastro di Volterra (foto: Alfonso Acocella)
Dopo la crisi mondiale del 1873 si notò un’appesantimento generale ed una maggior concorrenza tra i produttori. Forse a causa della improduttiva coesistenza di fabbriche e piccole botteghe artigiane, sicuramente sintomo di una generale recessione economica, la crisi cominciò lentamente a maturare. La qualità della produzione iniziò a diminuire ed il fenomeno dei viaggiatori a scemare, fin quando si arrivò al vero e proprio crollo del 1879 per la cui soluzione tante furono le proposte: dall’istituzione di un deposito unico al blocco dell’esportazione del materiale greggio, che, pur contribuendo al risollevamento della sorte di questa pietra, aprirono un nuovo ciclo di alterne fortune che si sono susseguite lungo tutto il corso del XX secolo.
Sara Benzi
Note
1 Fiumi E., La manifarrura degli alabastri, Nistri-Lischi ed., Pisa, 1980, p.9.
2 La parola “alabastro” compare come indicazione di “vaso” sia nella lingua greca che in quella latina, anche se non è chiaro se il termine indicava l’oggetto o il materiale con cui questo era prodotto. Origini antiche del suo utilizzo si trovano in Egitto: sembra che in questo Paese fosse esistita una città denominata “Alabastron” la cui principale attività manifatturiera era appunto la produzione di vasi ed anfore in alabastro destinate alla conservazione dei profumi.
3 Cave di alabastro gessoso si trovano anche nella zona del senese, in Romania, Francia, Spagna, Inghilterra e Brasile.
4 Le “anime” o “Ave Marie” erano chicchi di alabastro prodotti in 12 misure diverse che, spediti in gran quantità a Roma, venivano qui rivestiti in maniera tale da sembrare false perle impiegate per confezionare rosari o per decorare abiti. Questo commercio fu attivo fino almeno alla fine del XIX secolo.
5 Enrico Fiumi afferma che Inghirami fu il primo a dare avvio all’estrazione dell’alabastro delle cave di Castellina Marittima.
6 Il più avventuroso fu Giuseppe Viti, fece conoscere l’alabastro a New York, Boston, Baltimora, nelle Indie Occidentali ed in America latina.
Bibliografia
– C. Bruni, “Luigi Albino Funaioli scultore volterrano dell’800”, in Rassegna Volterrana – Rivista d’arte e di cultura, Anni LIV-LV, Accademia dei Sepolti ed., Volterra, 1979
– M. Cozzi, Alabastro – Volterra dal Settecento all’Art Deco, Cantini ed., Firenze, 1986
E. Fiumi, La manifattura degli alabastri, Nistri-Lischi ed., Pisa, 1980
B. Hartmann, L’alabastro tra arte e produzione di massa –Storia di un artigianato artistico a Volterra, Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A., Pisa, 1993
M. Pieri, L’Alabastro di Volterra, Quaderni sulla produzione pisana della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Pisa, Pisa, 1951
 A seguito di un articolo apparso su Il Sole 24 Ore del 5 ottobre 2005, nel quale veniva messa in luce una situazione di confusione nel settore del marmo, il presidente dell’Assomarmi, Cesare Bellamoli, ha fatto esplicita richiesta di chiarimenti in merito alla rappresentanza dell’industria marmifera italiana.
A seguito di un articolo apparso su Il Sole 24 Ore del 5 ottobre 2005, nel quale veniva messa in luce una situazione di confusione nel settore del marmo, il presidente dell’Assomarmi, Cesare Bellamoli, ha fatto esplicita richiesta di chiarimenti in merito alla rappresentanza dell’industria marmifera italiana.
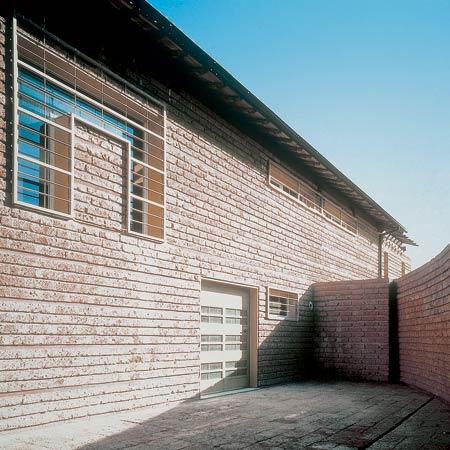


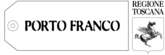
 Si è svolta recentemente a Milano un incontro del Comitato “Promotion Materiali” di ASSOMARMOMACCHINE, il gruppo di lavoro interno all’Associazione che si occupa di temi specificamente attinenti al comparto materiali lapidei. Gli argomenti all’ordine del giorno hanno riguardato da vicino problematiche di stretta attualità, dall’iniziativa “Pietra Autentica” alla promozione sugli architetti, dall’attività normativa in ambito CEN TC 246 al Contratto Tipo per le forniture lapidee.
Si è svolta recentemente a Milano un incontro del Comitato “Promotion Materiali” di ASSOMARMOMACCHINE, il gruppo di lavoro interno all’Associazione che si occupa di temi specificamente attinenti al comparto materiali lapidei. Gli argomenti all’ordine del giorno hanno riguardato da vicino problematiche di stretta attualità, dall’iniziativa “Pietra Autentica” alla promozione sugli architetti, dall’attività normativa in ambito CEN TC 246 al Contratto Tipo per le forniture lapidee.