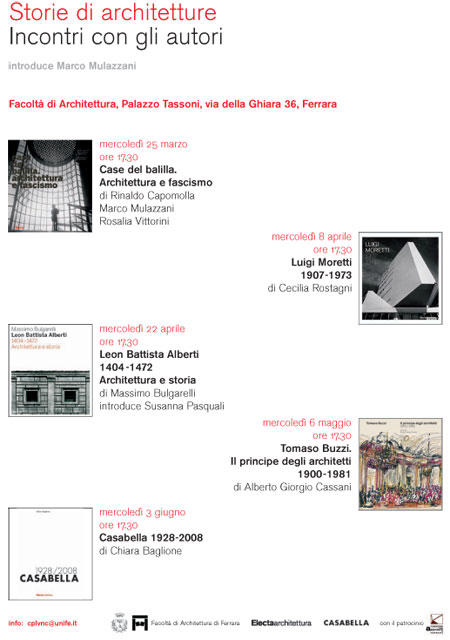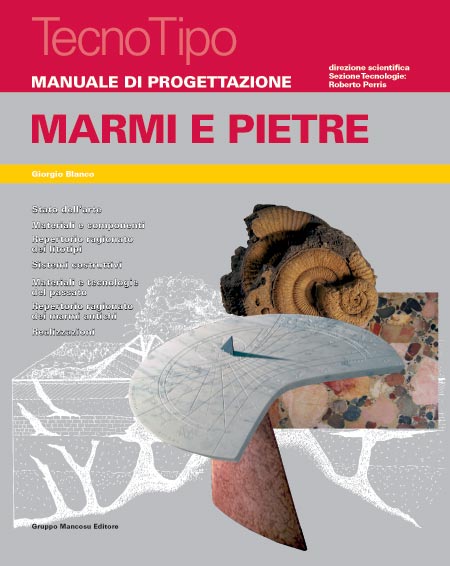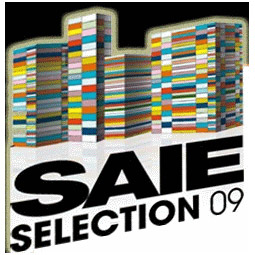20 Marzo 2009
News
Costruzione in pietra massiccia in Svizzera

«Non ci aspettiamo proprio niente da materiali in sé, ma soltanto dal loro uso corretto. Persino i nuovi materiali non ci garantiscono alcuna superiorità.
Ogni materiale ha solo il valore che da esso sappiamo trarre.»1
Questa citazione di Mies van der Rohe, che risale al 1938, conserva ancora oggi il suo valore di incitamento per il lavoro del progettista, sia esso architetto o ingegnere, anche, e soprattutto, per chi si confronta con il materiale lapideo. In effetti, se le qualità di un materiale non possono essere legate a criteri di valutazione temporali, la pietra naturale è, potenzialmente, adatta all’impiego nella costruzione contemporanea. Penso che l’esistenza stessa di architetturadipietra.it e il numero dei contributi raccolti siano una dimostrazione delle possibilità d’applicazione contemporanee di questo materiale. Le nuove esigenze imposte alla costruzione, siano esse legate al risparmio energetico, allo sviluppo sostenibile o alla razionalità di messa in opera, costituiscono nuovi parametri per la verifica della correttezza nell’utilizzo dei materiali. La pietra naturale è da sempre il materiale edile per eccellenza e sembra quindi impossibile che non lo possa rimanere anche oggi. Il caso del suo utilizzo strutturale e in forma massiccia ne è un esempio, come recentemente illustrato dall’articolo di Davide Turrini “Architetture contemporanee in pietra strutturale” apparso il 2 marzo . Vorrei tornare sull’argomento e per presentare brevemente la ricerca “Costruzione in pietra massiccia in Svizzera” che svolgo attualmente come tesi di dottorato in architettura presso il Politecnico Federale di Losanna in Svizzera.
La ricerca è lo sviluppo del progetto di Master “La Via della Pietra” presentato presso il Politecnico di Losanna nel maggio 2006 (vedi posts nella categoria “Paesaggi di pietra“). Grazie al sostegno dei Professori Luca Ortelli, del Laboratoire de Construction et Conservation 2, e Aurèle Parriaux, del Laboratoire de Géologie de l’ingénieur et de l’Environnement, un progetto per lo studio di nuove soluzioni per l’applicazione della pietra naturale massiccia nella costruzione è stato elaborato nel 2006. L’anno successivo ha ricevuto il sostegno del Fondo Nazionale Svizzero della Ricerca Scientifica che ne sostiene lo sviluppo. L’importanza di questo riconoscimento, oltre che da un punto di vista finanziario, è importante poiché dimostra un’interesse a livello nazionale per la pietra naturale. Nel novembre 2007 è dunque iniziata la mia tesi di dottorato in architettura il cui relatore è il Prof. Luca Ortelli.
La struttura della ricerca si sviluppa a partire da due assunti. Il primo è che il ricorso a materiali locali per la costruzione sarà in futuro necessario non solo per delle ragioni di salvaguardia ambientale e di sviluppo sostenibile, ma anche per ritrovare un legame tra territorio ed edifici. Il secondo principio è la necessità di analizzare il materiale “pietra naturale” dalla risorsa alla demolizione dell’edificio, ovvero un’analisi completa del ciclo di vita, affinché i vincoli posti da ciascuna fase possano diventare elementi positivi della progettazione. Un principio simile a quello impiegato nelle opere in pietra di architetti quali Gilles Perraudin, Fernand Pouillon, Jorn Utzon oppure dagli anonimi costruttori del passato.
Lo scopo finale è di proporre delle soluzioni per permettere di reintrodurre la pietra naturale massiccia nel settore edilizio. Ciò attraverso soluzioni costruttive e principi che ne permettano un approvvigionamento duraturo e sostenibile da un punto di vista ambientale.
Visto il carattere interdisciplinare dei temi trattati diverse collaborazioni sono in atto sia in seno al Politecnico Federale di Losanna sia con altri istituti, associazioni e ricercatori, sia a livello nazionale sia europeo.
La ricerca si divide dunque in tre categorie principali. La prima concerne la risorsa, ovvero lo studio geologico, petrografico e meccanico delle pietre naturali svizzere ancora estratte. Ogni pietra possiede delle caratteristiche differenti, che, se conosciute, possono, determinarne l’ambito di impiego. Questa prima parte permette di individuare le pietre adatte all’utilizzo strutturale.
La seconda parte è dedicata allo studio dell’industria estrattiva svizzera contemporanea. La conoscenza diretta delle cave e delle tecniche utilizzate nell’estrazione e nella trasformazione permette di stabilire le dimensioni dei blocchi estratti. Da queste ultime si possono, in seguito, determinare le dimensioni degli elementi modulari. L’adattamento fra blocchi estratti e elementi costruttivi permette di ridurre gli scarti migliorando lo sfruttamento della risorsa. Le cave studiate sono quelle più rappresentative per dimensione e tecnologie applicate. Lo studio dell’industria ha permesso di tracciarne il profilo attuale di questo settore economico (gli ultimi studi a scala nazionale risalivano agli anni 90 del XX secolo). Il numero delle cave svizzere di pietra per la costruzione è diminuito del 90% in un secolo. In effetti, nel 1915 esistevano circa 700 cave contro le attuali 70.
In futuro si cercherà di proporre delle strategie per garantirne la sopravvivenza.
Una “biblioteca delle pietre svizzere” per applicazioni strutturali raccoglie, in forma di schede per ogni tipo di pietra estratta, i valori numerici risultanti dai punti sopraccitati.
Nella terza parte è trattato l’argomento specifico della costruzione in pietra massiccia. Non potendo affrontare tutti i tipi di costruzione, il caso dell’abitazione è stato scelto sia per la sua diffusione sia per i vincoli che esso impone al progettista, soprattutto in termini di confort, sicurezza e economia. Si è inoltre deciso di approfondire il tema della muratura in pietra, escludendo dunque il tema delle volte. Le normative vigenti servono come basi di verifica per le soluzioni elaborate. Le principali verifiche riguardano la resistenza sismica, il confort interno e il consumo energetico. Le soluzioni costruttive sono sviluppate partendo dalle caratteristiche di ogni tipo di pietra e affinate attraverso il confronto con le esigenze contemporanee in materia di abitazione e sviluppo sostenibile.
Per esempio, la verifica sismica è stata effettuata, in collaborazione con il Laboratoire d’Informatique et Mécanique Appliquées à la Construction del Politecnico Federale di Losanna, su delle murature non armate per degli edifici abitativi di altezza compresa tra i quattro e i sei piani (altezza media per questo tipo in Svizzera) utilizzando le normative vigenti. I risultati ottenuti convalidano la possibilità di utilizzare questo sistema costruttivo nella maggior parte del Paese. Il fatto di poter utilizzare murature non armate permette non solamente una riduzione dei costi, ma anche di evitare problemi di corrosione tra metallo e pietra oltre che a facilitare il riutilizzo dei conci dopo la demolizione dell’edificio. Soluzioni tecnicamente più complesse sono dunque necessarie solo in caso di un forte rischio sismico.
La ricerca è volta quindi, da un lato, all’elaborazione di un metodo di progettazione per la pietra naturale strutturale e, dall’altro, alla produzione di risultati numerici, laddove possibile, che ne permettano la convalida. Il desiderio è quello di trovare un giusto equilibrio tra dati derivanti da una precisa situazione temporale e geografica e princìpi di valore “universale”. Tutto ciò per contribuire ad un “utilizzo corretto” della pietra naturale.
Stefano Zerbi
Note
1 Ludwig Mies van der Rohe, “Discorso inaugurale in qualità di direttore del dipartimento di Architettura presso l’Armour Institute of Technology (AIT)” tenuto il 20 novembre 1938.
In: Fritz Neumeyer, Ludwig Mies van der Rohe. Le architetture, gli scritti, Milano, Skira editore, 1996, p. 307.